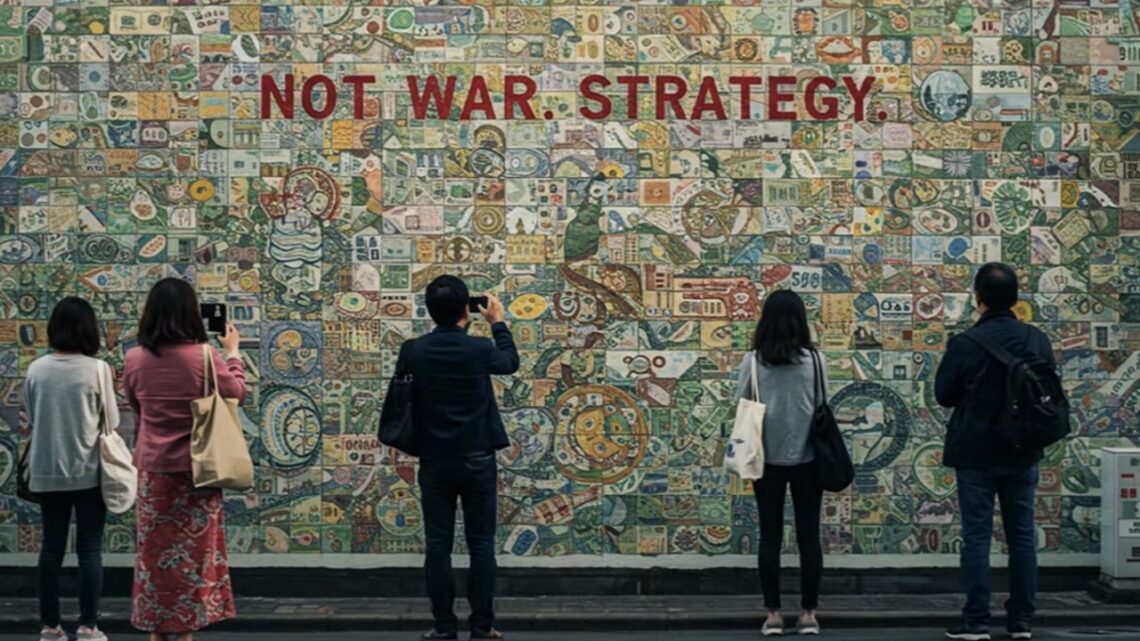
Meglio un disarmo progressivo e reciproco. Il riarmo alimenta l’insicurezza e fa malissimo all’economia
Tornare alla cultura e alla pratica del disarmo e della diplomazia. Riarmo e aumento delle spese militari non incrementano la sicurezza né fanno bene all’economia
Il mito della sicurezza armata: perché il riarmo non garantisce nè pace né stabilità
Nella retorica corrente e nella propopaganda bellica si sostiene che le spese militari ed il riarmo abbiano un’effetto positivo sull’economia ma è davvero così?
SIPRI – Rapporto 2025
Oltretutto finanziare a debito la spesa militare quali conseguenze può avere?
Chi davvero guadagna dall’incremento delle spese militari?
E i cittadini?
Il mito della sicurezza armata: perché il riarmo non garantisce nè pace né stabilità
La crescente insicurezza globale rappresenta la giustificazione che molti governi adottano per aumentare massicciamente la spesa militare con l’idea che più armi significhino più sicurezza. Tuttavia, questo approccio è inefficace e controproducente.
Il primo paradosso è quello della sicurezza percepita: ciò che uno Stato considera un rafforzamento difensivo, altri lo interpretano come un gesto ostile. Questo meccanismo, noto come security dilemma, alimenta la corsa agli armamenti, riduce la fiducia e rende più probabili gli incidenti o i conflitti. La corsa agli armamenti tra le potenze europee nel decennio che precedette la Prima Guerra Mondiale ne fu un esempio tragico.
In secondo luogo, un apparato militare sproporzionato può indurre a scelte avventate. Quando una nazione si sente in vantaggio bellico, può essere tentata di lanciare guerre “preventive”, ritenute necessarie per conservare o espandere la propria influenza. È il caso del Giappone imperiale nel 1941, che attaccò Pearl Harbor (peraltro con il beneplacito degli USA che avevano bisogno di convincere gli statunitensi che fosse necessario scendere in guerra per difendersi) per prevenire il crollo della propria egemonia nel Pacifico.
Anche sul piano interno, l’equazione “più armi = più sicurezza” non regge. La sicurezza reale dipende piuttosto dalla coesione sociale, da infrastrutture efficienti e in buono stato, l’istruzione, la salute pubblica e la stabilità economica. Quando la spesa militare drena risorse da questi settori, può innescare disuguaglianze, tensioni sociali e fragilità sistemiche. L’Unione Sovietica, economicamente strangolata da decenni di iper-militarizzazione nella corsa agli armamenti del periodo della guerra fredda ne rappresenta un esempio eloquente.
Inoltre, l’accumulo di potenza militare non incentiva il dialogo. Al contrario, spesso inibisce la diplomazia e spinge gli Stati a ritenere la forza l’unico strumento efficace. La Guerra Fredda fu dominata da questa logica, con un mondo paralizzato dalla minaccia reciproca, dove la pace era mantenuta non da accordi, ma dall’equilibrio del terrore del reciproco annientamento. La MAD Mutual Auto Destruction.
La violazione del principio della indivisibilità della sicurezza nello spazio europeo con l’espansone della NATO ad Est sino ai confini della Federazione Russa con l’ulteriore minaccia di aggiungere l’Ucraina nella NATO ha provocato il conflitto in Europa tra NATO/Ucraina e Russia.
Infine, il riarmo di una singola potenza può destabilizzare intere regioni. In Medio Oriente, i conflitti armati alimentati da forniture militari esterne – come nel caso di Israele e prima nella guerra Iran-Iraq.
Ovviamente la sicurezza autentica non nasce dall’arsenale, ma dalla capacità di costruire fiducia, cooperazione e sviluppo condiviso. Un mondo più armato non è necessariamente un mondo più sicuro; spesso, è semplicemente un mondo più vicino al conflitto.
L’Ucraina, con il 30% del PIL destinato alla difesa, ha avuto come risultato un paese distrutto e milioni di profughi. La sicurezza non deriva dalle armi, ma da rapporti diplomatici finalizzati alla collaborazione con il mondo. “Rearm Europe”, il riarmo a debito dell’Unione Europea, rischia di fare della Germania che grazie alle sue politiche mercantiliste e all’euro ha la forza economico-produttiva per riarmarsi un pericolo già visto nel corso di due guerre mondiali. Una Germania riarmata renderà l’Europa molto più insicura. L’Europa si è inimicata la Russia, la Cina e ora gli Stati Uniti di Trump. Un mondo in cui gli squilibri economici prevalgono pieno di sempre più armati con armi sempre più sofisticate non è un posto sicuro. Il conflitto tra paesi debitori e paesi creditori degenera in guerra. Enormi deficit (paesi indebitati con il resto del mondo) da una parte ed enormi surplus (paesi creditori) dall’altra creano tensioni sistemiche che rendono impossibile la cooperazione tra i popoli. Non è a caso che la parola pagare contiene in se la radice pace… La lotta per l’accaparramento delle risorse e per il loro controllo a scapito di quei paesi che le detengono fa il resto. È piuttosto necessaria un’altra forma dell’economia (vedi Dall’economia di guerra ad un’economia di pace).
Corsa al riarmo e crisi economica si alimentano a vicenda in un circolo vizioso, una spirale pericolosa. L’unica alternativa alla catastrofe sta nella attivazione di processi di disarmo reciproco e progressivo. La proposta è di ridurre progressivamente le spese militari, incentivare cooperazione e diplomazia ed aiuto allo sviluppo dei paesi più in difficoltà.
Occorre iniziare dalle armi più offensive per arrivare a tutte le armi offensive (bombe atomiche, missili a lungo raggio e a medio raggio, bombardieri, portaerei, droni, armi chimiche e biologiche e armi di nuova concezione). Tutti i paesi devono presto fare del disarmo una battaglia politica mondiale per ricostruire un rapporto positivo e sicuro tra i popoli. Nel caso della diatriba sul presunto armamento nucleare iraniano e la volontà di muovere guerra al paese mediorientale da parte del duo Israele-Usa bisogna chiedersi come mai nessuno chieda piuttosto il disarmo atomico di Israele.
Nella retorica corrente e nella propopaganda bellica si sostiene che le spese militari ed il riarmo abbiano un’effetto positivo sull’economia ma è davvero così?
In realtà le risorse destinate alla difesa sottraggono fondi a settori come istruzione, sanità, ricerca, infrastrutture, che hanno un impatto diretto più alto sul benessere collettivo e sulla produttività di lungo termine. Questo è noto come effetto di spiazzamento. La spesa militare ha, inoltre un moltiplicatore economico assai più debole e spesso negativo (fa diminuire il PIL) rispetto a quella civile: crea meno occupazione diretta, stimola meno consumi e genera meno innovazione “trasferibile” all’economia civile, soprattutto se orientata a tecnologie segrete o distruttive.
La crescita economica alimentata da spese belliche è un fuoco di paglia temporanea e fittizia. Può gonfiare il PIL nel breve termine, ma non crea basi strutturali per lo sviluppo (come istruzione o capitale umano), e spesso lascia in eredità debito pubblico eccessivo e instabilità.
Un’economia militarizzata tende a promuovere la competizione geopolitica e scoraggia investimenti esteri, cooperazione scientifica e flussi commerciali pacifici, tutti elementi chiave per la crescita economica moderna.
Un aumento delle spese militari è sempre un segnale di tensione o aggressività verso gli altri paesi. Peggiora il clima politico e riduce la fiducia degli investimenti nell’economia reale indirizzandoli unicamente agli investimenti finanziari nel settore bellico.
Investire in armamenti non genera valore sociale duraturo. Produce piuttosto “beni negativi” (armi, distruzione) invece di migliorare il capitale umano o ambientale.
Joseph Stiglitz (premio Nobel per l’economia, tra i principali critici del militarismo economico USA) e Linda Bilmes in The Three Trillion Dollar War (2008) hanno sostenuto che i costi nascosti delle guerre (Iraq e Afghanistan) superano ampiamente i benefici, drenando risorse pubbliche, indebolendo il welfare e generando debito. Essi affermano che i costi della guerra vanno oltre le spese dirette, includendo impatti macroeconomici come l’aumento del debito pubblico e la riduzione degli investimenti in infrastrutture e istruzione. (Stiglitz and Bilmes: The True Cost of the Iraq War – Economist’s View, [PDF] THE THREE TRILLION DOLLAR – Columbia Business School)
Così Seymour Melmam in The Permanent War Economy (1974) sostiene che l’economia statunitense si è “militarizzata” a scapito della competitività industriale e dell’efficienza civile, con gravi distorsioni a lungo termine. Melman critica l’economia di guerra permanente degli Stati Uniti, evidenziando come la spesa militare eccessiva abbia distorto l’economia civile. Egli sostiene che l’enfasi sulla produzione militare ha portato a una riduzione degli investimenti in settori produttivi civili, compromettendo la competitività industriale e l’efficienza economica complessiva. Gli fa eco Noam Chomsky il quale afferma che l’industria della difesa è parte di un sistema che concentra il potere e impoverisce la società, frenando lo sviluppo umano. Il SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) si affanna a ribadire che l’aumento degli investimenti bellici tende a frenare lo sviluppo sostenibile, soprattutto nei paesi in via di sviluppo.
Chomsky in un intervista su Jacobin (2022) critica l’aumento del budget militare, affermando:
“Ogni volta che aumentiamo il nostro budget militare, stiamo attaccando noi stessi.” (Noam Chomsky: “Every Time We Build Up Our Military Budget, We …)
L’economista Mark Blyth dimostra che l’eccessiva dipendenza dalle spese militari è un segnale di debolezza industriale e crea dipendenza da un’economia basata sul conflitto piuttosto che sull’innovazione civile.
Tutti sottolineano come le risorse destinate alla spesa militare potrebbero essere meglio impiegate per affrontare problemi interni come la sanità, l’istruzione e le infrastrutture.
SIPRI – Rapporto 2025
Il Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) ha riportato che nel 2024 la spesa militare globale ha raggiunto i 2.718 miliardi di dollari, con un aumento del 9,4% rispetto all’anno precedente. Il SIPRI avverte che questa tendenza potrebbe avere conseguenze sociali ed economiche durature, poiché le risorse vengono deviate da settori essenziali come la sanità e l’istruzione verso la difesa. (World military spending hits $2.7 trillion in record 2024 surge)
Oltretutto finanziare a debito la spesa militare quali conseguenze può avere?
A differenza di investimenti pubblici in infrastrutture, ricerca civile o istruzione, la spesa militare non genera rendimenti economici futuri. Se finanziata a debito, aumenta il carico fiscale futuro senza aumentare la capacità produttiva del Paese.
Quando la spesa militare è sostenuta per lungo tempo attraverso l’indebitamento, lo Stato può entrare in una spirale di deficit strutturale, in cui nuovi prestiti servono solo a pagare interessi su debiti precedenti (effetto “palla di neve”) e questa è già la situazione tipica di tanti paesi che hanno già un grosso debito pubblico con cui fare i conti anche perché la finanza pubblica è stata sovvertita a favore dei grandi mercati finanziari. Il governo, emettendo debito per sostenere la spesa militare, assorbe, infatti, capitali dai mercati finanziari sottraendoli a quelli disponibili per investimenti privati produttivi. Questo rallenta la crescita e penalizza l’innovazione.
Un forte ricorso al debito pubblico innalza i tassi d’interesse nel lungo periodo. Inoltre, in contesti di piena occupazione o tensioni geopolitiche, contribuisce a spingere l’inflazione, aggravando le disuguaglianze sociali.
Un Paese fortemente indebitato per sostenere spese militari può essere percepito come instabile o aggressivo, riducendo la fiducia degli investitori stranieri, danneggiando il rating sovrano e innescando fughe di capitali.
È inevitabile che spese militari finanziate a debito possano contribuire alla crisi del debito sovrano in paesi come l’URSS negli anni ’80, l’Argentina nei ‘90, o gli USA dopo la guerra in Iraq.
Il debito militare è uno dei più rischiosi in termini macroeconomici, perché non crea asset produttivi, può generare instabilità fiscale e politica, e tende ad alimentare conflitti invece che crescita.
Un esempio emblematico è il crollo dell’Unione Sovietica, spesso citato dagli economisti come un caso di crisi economica alimentata dal debito militare. Così nel caso degli USA dopo la guerra in Vietnam che portò ad alta inflazione e disavanzi fiscali negli anni ’70. L’Argentina negli anni ‘80 con spese militari nella guerra delle Falkland, seguite da iperinflazione e default o più indietro nel tempo la Germania nazista con il suo boom militare insostenibile che portò il paese al collasso post-bellico.
Chi davvero guadagna dall’incremento delle spese militari?
I principali beneficiari non sono certo i cittadini né la sicurezza collettiva, bensì interessi economici e politici specifici legati al complesso militare-industriale.
Grandi aziende come Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, BAE Systems (in Europa), producono armi, tecnologie e sistemi di difesa. Per queste imprese, l’aumento della spesa militare è direttamente proporzionale ai profitti. Più guerre, minacce o escalation = più contratti pubblici.
Il presidente USA Dwight D. Eisenhower, ex generale, lo denunciò già nel 1961:
“Dobbiamo guardarci dall’influenza ingiustificata, ricercata o meno, del complesso militare-industriale. […] C’è un rischio che il potere stesso sfugga al controllo democratico.”
La retorica del riarmo può servire a creare coesione nazionale, deviare l’attenzione da problemi interni e rafforzare il potere dell’esecutivo, soprattutto in tempi di crisi o in regimi autoritari. La “minaccia esterna” giustifica decisioni eccezionali e spese straordinarie.
Molti centri di ricerca geopolitica e sicurezza, spesso finanziati da aziende della difesa, contribuiscono a formare il discorso pubblico e le agende politiche, promuovendo un clima di allarme che giustifica il riarmo. Alcuni esempi includono RAND Corporation o CSIS negli USA.
Gli investitori in azioni delle aziende belliche e fondi militari traggono profitto da ogni nuova ondata di spesa militare. L’aumento dei conflitti porta a impennate in borsa per questi titoli.
I grandi paesi produttori di armamenti vedono nell’export bellico una leva geopolitica e commerciale. Questo genera interdipendenze pericolose: alleati mantenuti a forza di armi, instabilità che alimenta nuove vendite.
E i cittadini?
Le popolazioni pagano il prezzo in termini di:
- riduzione della spesa sociale
- impoverimento di altri settori strategici (sanità, istruzione, ambiente)
- aumento del rischio di conflitto con tutto ciò che ne consegue
- ridotta trasparenza democratica
Il già citato Seymour Melman, economista e sociologo statunitense ha scritto:
“Making and selling weapons has become more profitable than producing goods people can actually use. War preparation has replaced productive investment. We are building the means to destroy rather than to sustain life.” “Produrre e vendere armi è diventato più redditizio che fabbricare beni utili alle persone. La preparazione alla guerra ha sostituito gli investimenti produttivi. Stiamo costruendo strumenti per distruggere, non per sostenere la vita.”
— Seymour Melman, “The Permanent War Economy,” 1974
È necessario ripartire dalla consapevolezza dello stato delle cose in merito ai trattati per la riduzione degli armamenti molti dei quali sono ormai scaduti, in scadenza e altri violati.
Eccone un quadro schematico
- Trattati Scaduti/violati
INF Treaty (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty)
• Stipulato: 1987 (USA-URSS)
• Scopo: Eliminare missili nucleari e convenzionali a raggio intermedio (500-5.500 km)
• Stato: Scaduto nel 2019 dopo il ritiro unilaterale degli Stati Uniti, seguito dalla Russia
• Motivo: Accuse reciproche di violazione (es. Russia con il missile 9M729 secondo gli USA)
ABM Treaty (Anti-Ballistic Missile Treaty)
• Stipulato: 1972
• Scopo: Limitare i sistemi antimissile strategici per mantenere la deterrenza nucleare
• Stato: Terminato nel 2002, quando gli USA si sono ritirati sotto l’amministrazione Bush
• Motivo: Interferiva con lo sviluppo dello scudo antimissile americano
START I (Strategic Arms Reduction Treaty I)
• Stipulato: 1991 (USA-URSS)
• Scopo: Riduzione di testate nucleari strategiche
• Scaduto: 2009, sostituito dal New START
- Trattati In Scadenza
New START (Strategic Arms Reduction Treaty)
• Stipulato: 2010 (USA-Russia)
• Scopo: Limitazione reciproca a 1.550 testate nucleari strategiche e 700 vettori
• In scadenza: Febbraio 2026 (dopo una proroga quinquennale nel 2021)
• Situazione attuale: Russia ha sospeso la partecipazione nel 2023, ma non ha formalmente abbandonato il trattato; gli USA continuano a rispettarne i limiti
- Trattati Violati o Contestati
Trattato INF (vedi sopra)
Trattato sul Cielo Aperto (Open Skies Treaty)
• Scopo: Sorveglianza reciproca tramite voli di ricognizione
• Violato/sospeso:
• USA si sono ritirati nel 2020, accusando la Russia di limitazioni non autorizzate
• Russia si è ritirata nel 2021
4. Trattato sulla Non Proliferazione Nucleare (TNP o NPT)
• Stipulato: 1968
• Scopo: Prevenire la diffusione delle armi nucleari
• Stato: Formalmente in vigore
• Alcuni Paesi non firmatari (India, Pakistan, Israele) possiedono armi nucleari; accuse di scarsa dismissione da parte delle potenze nucleari.
C’è molto da fare. I cittadini devono farsi rapidamente consapevoli e valorizzare pienamente gli spazi di democrazia residua per ampliarla ed abbattere tutti quei quadri dirigenti che alimentano la logica del sistema di guerra lavorando per il ritorno al welfare rigettando con determinazione qualsiasi politica di warfare prima che sia troppo tardi.
articoli correlati a cura dell’autore
Star Wars. La militarizzazione dello spazio
Gli squilibri economici ristrutturano il mondo Rimettere in primo piano l’economia interna
Armarsi a debito. La Finanza armata dell’Unione
L’Armata Brancaleone europea dopo la mascherina indossa l’elmetto per salvare la finanza con i nostri risparmi
Euromissili statunitensi in Germania per difenderci?
Le prime ore del conflitto provocherebbero più di 90 milioni di persone uccise e ferite
START… fine dell’operazione militare speciale INIZIO di una guerra di lunga durata?
Un Paese incateNATO
Quale soluzione per squilibri economici che degenerano in guerra
Far soldi con i soldi dissociandosi dai bisogni dell’economia produttiva. Fino a quando?
Crepe profonde nel sistema economico occidentale
Gli USA hanno vinto la guerra contro l’Europa
Dialogo tra mondi? Le condizioni della Pace
Le condizioni economiche della guerra da Biden a Trump
L’eroica ucraina, baluardo del mondo libero, contro l’imperialismo russo?
© COPYRIGHT Seminare domande
divieto di riproduzione senza citazione della fonte
canale telegram di Seminare domande
https://t.me/Seminaredomande
Iscriviti per ricevere notifica ad ogni nuovo articolo